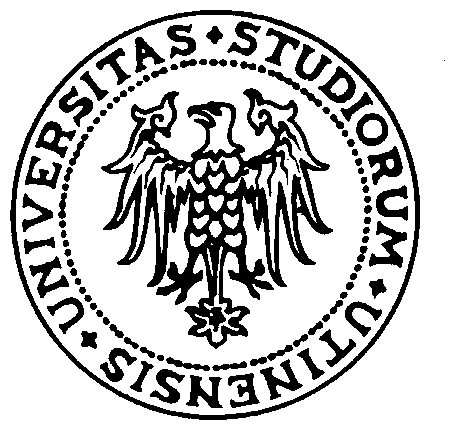
Scheda studente A3_ 2.1 Fotosintesi
a cura di Laura Decio
revisione Marisa Michelini e Lorenzo Santi
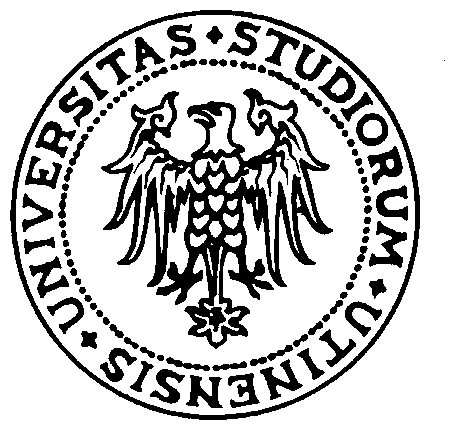 |
Progetto LabTec
Scheda studente A3_ 2.1 Fotosintesi a cura di Laura Decio revisione Marisa Michelini e Lorenzo Santi |
A3 - 2.1 Fotosintesi
LetturaLa fotosintesi clorofilliana è un processo che porta alla trasformazione di
energia associata alla radiazione luminosa (luce) in energia interna di un
sistema in cui avvengono trasformazioni chimiche (energia chimica).
Il processo viene tradizionalmente sintetizzato dalla seguente equazione:
![]()
dove
CO2 = anidride carbonica
H2O = acqua
C6H12O6 = glucosio
O2 = ossigeno
L’equazione chimica che sintetizza il processo fotosintetico potrebbe far
pensare che il glucosio si forma per interazione diretta tra anidride carbonica
e acqua, ovviamente in realtà questo non è vero e il processo fotosintetico
avviene in diversi passaggi complessi che coinvolgono altre molecole che non
compaiono nella equazione sintetica.
La fotosintesi comprende due fasi nettamente distinte:
Le reazioni di questo processo metabolico si svolgono nei cloroplasti che sono organuli cellulari specializzati per effettuare la fotosintesi ; all’interno del cloroplasto le due fasi sono localizzate in zone diverse. La maggior parte degli enzimi che catalizzano la reazione della fase oscura si trovano nello stroma , i protagonisti della fase luminosa sono nelle membrane dei tilacoidi.
Durante la fase luminosa l’energia luminosa viene catturata da fotosistemi (clorofille e pigmenti accessori) che assorbono l’energia dei fotoni eccitandosi (facendo cioè saltare un elettrone da un orbitale ad energia più bassa ad un orbitale ad energia più elevata) e sono in grado di eccitare altri pigmenti attraverso un trasferimento di energia per risonanza ( in cui ogni molecola trattiene i suoi elettroni e viene trasferito solo lo stato di eccitazione) fino ad arrivare ad eccitare una molecola di clorofilla a che è in grado invece di tornare allo stato fondamentale cedendo il suo elettrone eccitato ad un’altra molecola; l’elettrone ceduto è utilizzato per far funzionare una catena di trasporto di elettroni; al termine di questa catena gli elettroni vengono ceduti al NADP riducendolo a NADPH che verrà utilizzato come riducente nella fase oscura. La catena di trasporto dei cloroplasti è complessivamente endoergonica ( richiede energia dall’esterno in questo caso dalla luce), ma una parte di questa è esoergonica e l’energia liberata viene usata per la sintesi dell’ATP che verrà utilizzato nella fase oscura. L’elettrone perso viene restituito ai fotosistemi attraverso la fotolisi dell’acqua che origina come prodotto l’ossigeno, parte di questo viene utilizzato direttamente per le attività metaboliche ossidative della pianta e parte viene emesso nell’atmosfera.
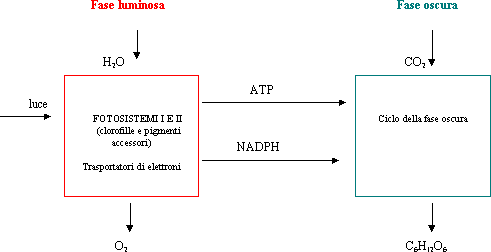
La fissazione della CO2 avviene nel ciclo della fase oscura che
comprende alcuni passaggi relativamente complessi in cui sono coinvolti zuccheri
fosfati ai quali viene legata l’anidride carbonica portando alla produzione di
glucosio (immagazzinato come amido). Questo è un processo energeticamente
dispendioso che le piante possono effettuare grazie all’ATP e al NADPH
prodotti a spese dell’energia luminosa
I prodotti del ciclo della fase oscura sono di importanza cruciale per l’intera
biosfera, infatti i legami covalenti presenti negli zuccheri prodotti
rappresentano la forma in cui viene chimicamente immagazzinata energia che
proviene dal Sole.
Esistono diverse modalità di fissazione della CO2 , il ciclo più
utilizzato è quello di Calvin che porta alla formazione di molecole a tre atomi
di carbonio e le piante che utilizzano questa via metabolica per la fissazione
dell’anidride carbonica vengono dette piante C3 , esistono però
altri tipi di piante che in presenza di CO2 non producono
un composto a tre atomi di carbonio ma un composto a 4 atomi di carbonio. Queste
piante, dette C4 effettuano il ciclo di Hatch e Slack, che presenta
un ciclo parallelo a quello di Calvin, che agisce da pompa della CO2
permettendo così di avere una efficienza elevata della fotosintesi anche in
presenza di un basso livello di CO2 all’interno della foglia. In
generale le piante C4 sono meglio adattate ad ambienti in cui possono
verificarsi periodi di scarsità di acqua, infatti per prevenire una eccessiva
perdita di acqua queste piante mantengono gli stomi fogliari chiusi per lungo
tempo determinando una bassa concentrazione di CO2 disponibile per la
fotosintesi; ma queste piante contengono un enzima che ha una alta affinità per
la CO2, che permette loro di compensare tale mancanza permettendo la
formazione di un composto a quattro atomi di carbonio che è poi in grado di
cedere nuovamente CO2 (per decarbossilazione) per il ciclo di Calvin.
In altre piante è attivo un sistema correlato, ma diverso, che permette di far
fronte a periodi di siccità più prolungati. I loro stomi sono regolati in modo
tale da aprirsi, e quindi di permettere l’accesso della CO2 , solo
di notte: sono le piante CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Sempre di notte l’enzima
già ricordato sopra permette l’immagazzinamento della CO2 che
viene resa disponibile di giorno, a stomi chiusi. La differenza tra i due
processi è che per le piante C4 la reazione viene catalizzata dalla
luce , mentre nelle piante CAM si utilizza un accettore di anidride carbonica
derivato dalla demolizioni degli zuccheri prodotti dalla respirazione cellulare